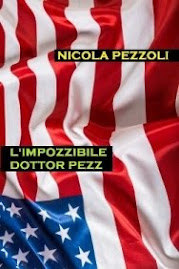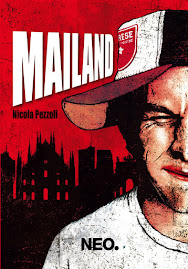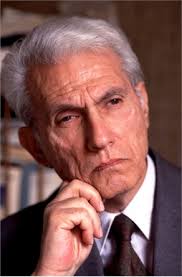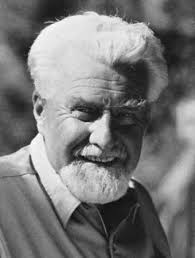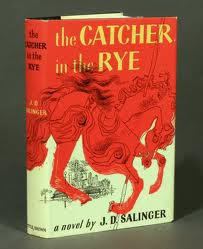Due sono i tratti da sempre all’origine della vera arte: un minimo di talento naturale che sta, necessariamente, alla base (checché ne dicano i truffatorelli del siamo tutti scrittori), e poi un’anima ferita, violentata, “grattugiata” come i muri delle case di certi immigrati nell’America dei primi del Novecento. L’anima ferita aiuta, non poco, a far scaturire i capolavori.
Due sono anche le storie qui portate avanti a capitoli alterni, come nei migliori romanzi di Vargas Llosa. Si tratta di capitoli brevi, intensi, incalzanti, che invogliano a divorare il libro, struggenti, dei piccoli dardi, avvelenati da una giusta rabbia, che centrano il cuore, ma il veleno è un veleno reso quasi piacevole dall’arte del saper scrivere, dalla magia dell’esprimersi, dal coraggio di vivisezionare un’infanzia brutalizzata e un’innocenza violata, incidendo a fondo pur sapendo che in tal modo sanguineranno ancora, e tanto, tanto.
Margherita, nel 1914, è una quindicenne toscana sedotta e ingravidata dal rampollo dei riccastri del paese, il quale si guarderà bene dal riconoscere il figlio, e costretta dagli eventi a imbarcarsi verso l’America non per rifarsi una vita ma per avere una vita, che grazie alla sua bellezza, intelligenza e forza di carattere decollerà oltre ogni aspettativa, ma resterà sempre orba di quel primogenito che ha dovuto abbandonare in un convento di suore per salvarsi dall’opprimente piccineria di un mondo che invece di chiamarti sfortunata, e aiutarti stringendosi vicino, ti chiama puttana, e ti condanna all’isolamento.
Emma, una sessantina di anni dopo, da bambina viene massacrata di botte, e da adolescente stuprata e ingravidata, dal padre, uno schifoduomo di quelli che ti fanno vergognare di essere maschio, di quelli che non ti sembra possibile esistano e invece te li ritrovi ogni giorno nella cronaca nera, in questo caso con la sola (insufficiente) attenuante della depressione, un demone che lo porterà a impiccarsi troppo tardi, fuori tempo massimo sul timing delle altrui vite devastate per sempre, irrimediabilmente.
Ma non si creda che il romanzo sia una di quelle poco oneste “fucilazioni” del maschio, con annessa glorificazione della bontà femminile: il primo personaggio negativo con cui facciamo conoscenza è la madre di Margherita: un’orrenda bigotta gelida e anaffettiva, capace soltanto di giudicare e di preoccuparsi dello scandalo al cospetto delle malelingue di paese (dopo il parto terrà la figlia segregata in casa, e quando poi seguirà il consiglio del medico di “farla uscire” sarà per spedirla come sguattera presso un disgustoso vedovo arrogante e bavoso), uno schifodidonna, insomma, come troppe ce ne sono. La piccola Emma, dal canto suo, ha una mamma dolcissima e colpevole solo di debolezza e sottomissione, vittima quanto lei, ma anche una sorella maggiore modello Empatia Zero, che la tratta come un’estranea e le nega ogni possibile spiraglio di complicità e consolazione.
Le due storie sono legate come una maledizione ereditaria: Margherita è la bisnonna di Emma (ma non sto “spoilerando”: se volessi farlo rivelerei le sorprese più grandi custodite nelle ultime pagine…)
«Quando Lui mi colpiva sentivo il sapore del sangue. Era pastoso e con il gusto di una vecchia chiave… Quanto durava il tempo dei pugni e dei calci? Pochi attimi. Il resto veniva dopo. Un affanno di rabbia muta attraverso il corpo. E la voglia di urlare, di correre via, di cambiare identità... Assumere le sembianze di un gatto randagio, di un pesce rosso, di un fiore, di un sasso. Ancora meglio, di una formica. Le formiche hanno uno scopo fermo, inossidabile: prendono una mollica, un pezzetto di qualsiasi cosa e lo trasportano. Lo fanno a prescindere. Nessuno le ferma. Puoi schiacciarne una, ma quelle che restano non hanno paura. Vanno avanti. Si riorganizzano. Ricominciano. Le formiche non hanno paura. Avrei voluto essere una formica.»
Una scrittura, quella di Silva Gentilini, asciutta ed efficace, di precisione chirurgica, e al tempo stesso coinvolgente, capace di evocare odori, suoni e sensazioni tattili facendoteli provare fisicamente, così come ti fa respirare l’ansia e l’angoscia. Leggendo vi si stringerà il cuore, e al contempo vi si dilaterà l’anima, e giunti alla fine vi verrà voglia di abbracciare l’autrice, per farle sapere che al mondo c’è anche chi invece di picchiare e violare preferisce amare e proteggere. Amare e proteggere i bambini, le donne, gli artisti.
Un romanzo che ti avvince e ti rimane addosso. Indubbiamente un libro che merita di essere letto: bello, tremendo, toccante, coraggioso. Come piacciono a me e ai buongustai che frequentano questo blog, e che come me odiano i rigurgiti delle mezzeseghe copincollerecce, i meteorismi mentali degli intellettualoidi della mutua, i peti a ripetizione di certi cacacommissari, i libercoli noiosi e superflui e quel tanfo di stantio che ha la fuffa troppe volte riciancicata.
Non fatemi incazzare.
Parola di Scriba.