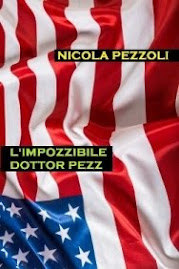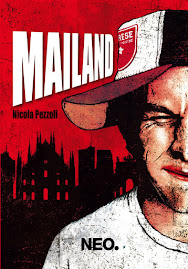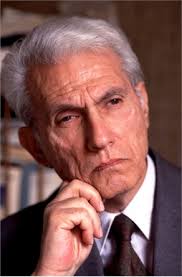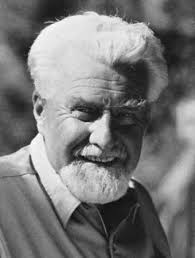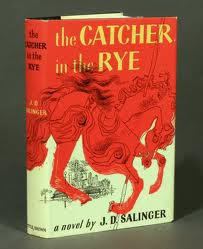LA VERA PASSIONE? QUELLA DI PAOLO PER LA SCRITTURA
CHE SPOSA, E NON TRADISCE, LA NOSTRA PER LA LETTURA
Come spesso accade nelle opere di questo grandissimo autore, il protagonista del Romanzo, Matteo De Angelis, è un antieroe contemporaneo: un individuo semplice e ordinario, ben inserito, almeno in apparenza, negli stritolanti ingranaggi della normalità.
Fin dalle prime pagine scopriremo che Matteo è un uomo buono ma tormentato, irrisolto, complesso: a contatto con lui si avverte lo strano influsso di una personalità che ci attrae e ci respinge, ci intenerisce e ci spaventa, perché forse lui è in una volta sola quello che siamo, quello che abbiamo rischiato di essere, e quello che non vorremmo mai dover essere.
Matteo che ha paura degli incubi e gli piacerebbe rinunciare al sonno (“invidiava gli squali sempre in movimento, con il loro mezzo cervello a fare la guardia sull’altra metà che riposava silenziosa”.) Matteo che vuole un bene dell’anima ai suoi piccoli gemelli identici, incarnato brivido e tenero mistero biologico (“A volte, la mattina, quando andava a svegliare i suoi figli, li sorprendeva distesi nello stesso letto, abbracciati. Temevano la notte? Sua moglie diceva che era perché avevano passato nove mesi uno accanto all’altro, nel ventre materno: come avrebbero potuto vivere separati una volta caduti nel mondo?” – e si noti la sublime bellezza di quel “caduti”) ma rischia di tarparne precocemente le ali dentro un familismo cattolico rincagnato e un po’ ottuso. Matteo che è ligio all’etica del lavoro e al senso del dovere: percepisce l’azienda come un’infernale macchina bellica, ma si adegua ai suoi meccanismi come un disciplinato soldatino (fiero di essere approdato a livelli di responsabilità e comando) ed è grato della sicurezza economica che gli elargisce mamma ditta, un mostro impersonale che nel nome, e non soltanto nel nome (Gestam), evoca vagamente la Gestapo. Matteo lo vorresti strozzare, ogni volta che descrive l’amorevole moglie come una specie di cagnolino, non bello ma fedele e rassicurante, che si può amare con affetto, riconoscenza e fantozziana “stima”, ma non certo con passione. Matteo lo vorresti abbracciare, perché è stato tradito alla nascita da un padre che non è mai stato un padre, e tredici anni dopo è stato ancor più atrocemente tradito dalla sciagurata madre, una beghina della provincia veneta che ha pensato bene di farsi ingravidare, durante una gita torpedon-suoresca a Roma, dal peggior partner possibile (“una cattolica devotissima che un giorno aveva deciso di fare sesso con il primo che capitava – cioè lui – e mettere fine ad una verginità dal gusto ottocentesco”) per poi vivere dilaniata dalla colpa, e che dopo aver cresciuto il povero bambino a bagnoMaria in quella superstiziosa religiosità di paese che in Italia sconfina spesso nella mariolatria (“A maggio, ogni sera alle nove, Matteo recitava il rosario con sua madre, in salotto, davanti a un quadretto della Madonna”) e averlo instradato verso il seminario, decide di impiccarsi, e di abbandonarlo nell’età più delicata.
Matteo ha tradito a sua volta la passione, che però continua a sopravvivere in lui sottopelle, come un remoto richiamo, come una parte crioconservata dell’ardente anima che fu, pronta a essere risvegliata dalle note di Bach, e dalla conturbante sensualità della sorellastra Giulia, conosciuta allorché fu spedito dal (non) padre in vacanza in Sicilia a pochi giorni dalla morte della madre (potenti i flashback su questa esperienza così straniante e rivelatrice, su questi giorni che sono per lui un lampo di luce nel momento più buio, questi primi giorni da orfano sperduto, così tetri eppure così incredibilmente, inaccettabilmente “felici”).
Giulia, oggi così diversa da lui da spiazzarlo coi suoi repentini sbalzi d’umore (“Sembrava avesse il ciclo ogni due ore”), con la sua mentalità alternativa, con la sua arruffata vita senza bussola (splendida la descrizione dello scantinato in cui abita con un provvisorio compagno:
“Dall’unica finestra del salotto si intravedevano le grate di un marciapiede; attraverso quelle fessure, i passanti avevano lasciato cadere per anni mozziconi di sigarette, carte di caramelle e stronzi di cane, fino a materializzare un Pollock in 3D”).
“Dall’unica finestra del salotto si intravedevano le grate di un marciapiede; attraverso quelle fessure, i passanti avevano lasciato cadere per anni mozziconi di sigarette, carte di caramelle e stronzi di cane, fino a materializzare un Pollock in 3D”).
Matteo sospetta che proprio la sensualità dell’allor quattordicenne Giulia lo abbia fatto sentire inadeguato e incompatibile con la vocazione di prete, inducendolo, in seguito, a lasciare dopo due soli anni il seminario, non per inseguire la vera passione, però, ma solo una via di mezzo fatta di lavoro salariato e matrimonio borghese. Matteo talvolta ti sconcerta, perché vedi che di quella vocazione inculcata sopravvivono in lui solo i lati-zavorra che lo rendono debole, passivo o ridicolo, come il segno della croce da pretino che si fa ogni volta prima di mangiare, o l’elogio conformista del grigiore (“Perché tanta pena nel cercare di diventare felici, quando si può essere normali? Cos’aveva la normalità di così terribile?”), ma soprattutto la totale disponibilità e remissività con cui obbedisce a tutto, compresa l’improvvisa chiamata del (non) padre (un uomo che per lui non è mai stato niente, e che sarebbe così facile, e forse normale, e forse giusto, mandare al diavolo), lasciandosi strappare dalle piccole gioie della famiglia al mare, e proprio nel momento in cui le cose sul lavoro stanno per andare a catafascio, non per sua colpa ma pur sempre durante la sua imperdonabile irreperibilità e assenza, così da configurare per lui e per la sua carriera una catastrofe caproespiatoria da pennacchiano Malaussène. (Il tutto aggravato dalla piena consapevolezza che Matteo ha dell’ingiusta situazione: “Matteo pensò a Giovanni, l’uomo che lo aveva generato, l’uomo per il quale era morta sua madre, e lo vide grande, altissimo, con dei fili in mano, intento a muovere le sorti del suo destino”.)
Sì, perché nel destino di Matteo c’è questo: un pazzesco viaggio in Ucraina in obbedienza alla misteriosa convocazione di Giovanni, con Giulia come compagna d’avventura.
Questo libro è una sinfonia struggente e malinconica. Non sto dicendo di aver seguito il consiglio di leggere il Romanzo ascoltando Bach: per me la Lettura è una magia silenziosa, e a produrre musica devono essere le parole, con in sottofondo gli accordi accorati del mio cuore emozionato. In più, come valore aggiunto, il compositore qui è anche un pittore che dipinge case, paesaggi e tramonti. Questi ultimi quasi sempre legati a Giovanni, un uomo al tramonto, prima a Venezia (“L’acqua sbatteva sulle fondamenta della casa come un respiro. I tramonti si triplicavano nel riflesso delle finestre e nel riverbero del canale”) e poi in Ucraina (“si rifletteva sulle migliaia di finestre dei palazzi e quell’incendio proletario creava uno spettacolo a suo modo suggestivo”), nella remota Voronyhrad in cui si è ritirato a morire adagio (“mi sta andando in malora il sistema nervoso. Il corpo ha attivato la procedura di autodistruzione senza chiedere il mio parere. La cosa fastidiosa è che sembra non abbia fretta: è come cadere dal decimo piano di un palazzo al rallentatore. Una morte alla moviola. Gliela sconsiglio vivamente.” racconta Giovanni a un criminale cui si è rivolto per procurarsi certe sostanze con cui vorrebbe accelerare il torturante processo, adesso che di quell’”adagio” non ne può più.)
E qui non potremo esimerci dal parlare di Giovanni (a costo di incappare nell’effetto “spoiler”: chi non vuol sapere “come va a finire” salti tutto questo paragrafo e approdi senza indugio al successivo): un uomo che questi spettacoli della natura forse non li merita (lui che nella sublime bellezza di Venezia ha sempre pensato unicamente a usare il pene, e a preoccuparsi in modo patetico allorché la vecchiaia ha cominciato a non farlo funzionare come prima, la solita crisi del cazzo di tutti i cazzoni del mondo); un uomo che per tutta la vita è stato un coitopiteco, di quelli convinti che “vivere” significhi trivellare più donne possibili; un uomo che è stato un giornalista leccapotenti, uno che si vanta di esser stato amico di Pol Pot e di essere andato a massacrare orsi con quell’altro porco del dittatore Ceausescu (pagine memorabili, queste della caccia che non è una caccia ma un tiro al bersaglio, una mattanza organizzata dagli sgherri, così come sono memorabili le pagine sull’”urlo primordiale” innescato da Giulia per aiutare Matteo a sfogarsi e liberarsi per la prima volta nella vita); un uomo abituato a mentire agli altri e a se stesso (pensa addirittura di riuscire a dare a bere di essersi stabilito in Ucraina non per seguire la badante che ha sposato in un impeto di disperazione – salvo poi scoprirla inadeguata all’ultimissimo compito – ma per pura curiosità socio-antropologica verso quelle terre di sfacelo post-sovietico); un uomo che potrebbe suscitare mille dibattiti su cosa sia o non sia in fin dei conti un padre biologico (un Padre non dovrebbe essere uno che ti ama e ti protegge anche se magari ti ha adottato, o si è preso cura di te come patrigno? E se uno ha solo fecondato un ovulo come incidente di percorso in una ginnica trombata, per poi sparire, il termine esatto sarà davvero “padre”?); un uomo che alla fine avrà il solo indiretto merito di condurci nei territori dell’Eutanasia, l’Argomento per eccellenza di questa nostra umanità che cerca faticosamente di diventare davvero civile, l’argomento capitale e tremendo di cui gli italiani, sottomessi alla Gestapo del Salvifico Dolore, hanno tanta irragionevole paura. Matteo sembra il meno adatto e invece è l’uomo perfetto: la sua riluttanza, anzi, il suo iniziale rifiuto (che ci fa ripensare ai momenti culminanti di quel meraviglioso film che è Million dollar baby, anche se qui il famoso e commovente “Mio tesoro, mio sangue” potrebbe esser ribaltato in un “Brutto stronzo, io ero il tuo sangue!”) farà sì che la sua non sia una mera esecuzione, ma l’atto amorevole di un angelo della misericordia. E l’atto stesso sarà perfetto per lui, portandolo a discostarsi una volta per tutte da quella chiazza di grigiore conformista e un po’ bigotto che aveva sino ad allora macchiato la sua vita: “Aveva tradito Dio per un senso di giustizia superiore, come i soldati che scelgono di non obbedire a un ordine ingiusto. Avrebbe affrontato il castigo a testa alta”.
Che altro dire, ancora? Io non sono mai troppo bravo nello scovare “parentele” letterarie (e non so nemmeno fino a che punto tale esercizio serva a qualcosa) ma è innegabile che leggendo Paolo Zardi se ne sentano sempre riecheggiare parecchi, di Grandi. Qui mi viene da pensare a Dostoevskij, a Cechov, a Nabokov (quello più sobrio di Disperazione e La difesa di Luzin), o anche, per le suggestioni ucraine ma non solo, al Safran Foer di Ogni cosa è illuminata.
Di Nabokov, verso la fine, troviamo una citazione che ho sempre condiviso in pieno: “in un libro contano solo la struttura e lo stile” (che non è affatto un inno allo sterile formalismo, perché lo Stile non è tale se non sa produrre emozioni su emozioni).
Ma soprattutto Zardi pare legatissimo alla lezione di Flaubert: prendere quella che potrebbe sembrare una brutta storia con brutti personaggi (in certi momenti, anche se non in tutti, sembra una gara a chi riuscirà a stare più sulle palle al lettore, proprio come in Madame Bovary) e riscattarla scrivendo in modo delizioso, facendoci godere per la bellezza delle descrizioni, la vividezza delle sensazioni, la coraggiosa profondità di un’introspezione mai banale, anzi, al contrario, da speleologo dell’anima, animato da una voglia di esplorazione intima ultimativa e quasi suicida.
Be’, amici miei, direi proprio che è il caso di comprarlo e di leggerlo.
Siete ancora lì?
Non fatemi incazzare.
Parola di Scriba.